Scritti premiati
Gli scritti premiati di Danilo Bottiroli e di Maria Elena Bottiroli sono pubblicati nell’omonimo libro che è possibile richiedere scrivendo a danilobottiroli@gmail.com
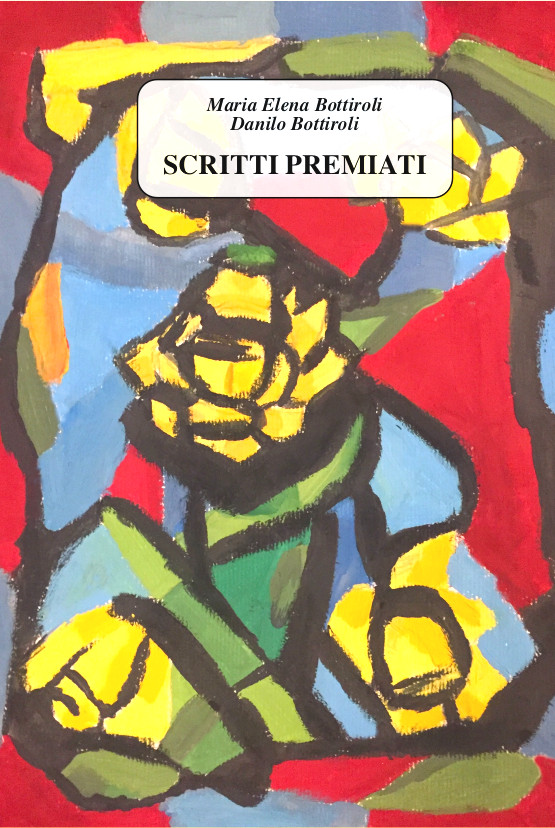
Per ricevere il libro occorre versare un contributo di € 7 secondo le modalità che saranno illustrate nella risposta alla richiesta tramite e-mail.
L’intero incasso sarà devoluto all’associazione Progetto Ambiente di Tortona.
I romanzi dell’autore non sono pubblicati su questo sito, ma sono reperibili in tutti i principali book store in Internet o nelle librerie.
Tutti gli scritti sono soggetti a copyright: sono vietati il plagio, la pubblicazione e la diffusione (anche parziali) a scopi di lucro.
Tutti gli scritti sono frutto esclusivo della fantasia dell’autore: ogni riferimento a persone o fatti realmente accaduti è da ritenersi puramente casuale.

RACCONTO DI NATALE
di Danilo Bottiroli
Tornavo a Genova per trascorrere il Natale con una vecchia zia e parenti più vicini a lei di me e mi sentivo come nella canzone di Paolo Conte: “Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così…”
Genova: ci tornavo dopo diversi anni che ora mi sembravano un’eternità.
Ci tornavo dopo averci vissuto ai tempi indimenticabili dell’università, fatti di libri e scoperte incredibili, di contestazioni nell’aula magna, di sigarette e giornali studenteschi, di peli ruvidi e labbra acerbe che non restavano nella memoria che per pochi mesi.
Ci tornavo con un po’ in anticipo rispetto al mio appuntamento con la zia e sconosciuti cugini in un bar di Via Balbi, per gustarmi di nuovo gli odori e i luoghi della mia giovinezza: Via del Campo e Via Venti, improbabili e diverse strade della stessa città; il vecchio centro storico con l’ombra di De André nascosta nei carruggi, luoghi di puttane e ladri, di pesce fresco e palazzi antichi nascosti nel perenne buio dei budelli; la nobile via Garibaldi con Palazzo Reale, Palazzo Bianco e Palazzo Rosso che custodiscono tesori dell’arte tra cui quel Caravaggio che ogni volta mi coglie di sorpresa, mi offusca la vista e mi fa girare il capo come fosse LSD, pane per la mente e per gli occhi.
Ritrovai piacevolmente Zena ancora al suo posto, come la ricordavo anni prima: confusa e superba bagascia bagnata dal suo unico mar Ligure, luogo di corsari del pensiero, di piccoli bottegai del centesimo, di filosofi, di conquistatori; terra di Colombo e Montale.
Genova, immobile rispetto agli uomini e al tempo, mi cullava nelle sue strade come una mamma dai seni cadenti, severa e vera.
Fuori dal bar di Via Balbi, in attesa di incontrare i miei più vicini lontani parenti, mi dedicai a osservare le persone che passavano.
Era un gioco crudele che avevo inventato già ai tempi della scuola: mi sedevo su una panchina dei giardini o andavo da solo in un locale e studiavo i passanti, guardavo com’erano vestiti, a volte ascoltavo i loro discorsi e immaginavo le loro vite.
Non lo facevo con tutti: certe persone non offrono alcuna possibilità di immaginazione.
Ma con qualcuno ha sempre funzionato.
Una donna sulla sessantina, vestita di nero con un velo di lana traforata, passò accanto al tavolino sulla via.
“Eccone una” pensai: negli anni Cinquanta ha lasciato il Sud d’Italia insieme al marito in cerca di lavoro. Lui era un tipo grezzo, alla fine obeso: calcio e politica da quattro soldi. Lei una donna persa, intelligente, creativa, rimasta ai fornelli, ad allattamenti che avevano un po’ sciupato due seni un tempo forti e duri, proprietà di un uomo solo; un uomo consumato dalle acciaierie dell’Ansaldo, morto di tumore e lei, ora, come in una canzone di Rino Gaetano, conservava il lutto di sempre.
Subito dopo passò un’altra donna: una prostituta di colore.
Lasciò una scia di profumo scadente dietro ad abiti da Via Pré.
Pensai al suo Senegal, a un villaggio nella Savana dove ogni mese inviava qualche euro per sfamare la famiglia; la madre e il marito la pensavano in Italia, con un lavoro decoroso, senza quella cicatrice, quello sfregio indelebile sulla guancia sinistra e nell’anima, malata di AIDS a sua insaputa.
Il terzo cliente della mia fantasia fu un uomo piccolo e paffuto, calvo e vestito in distinto gessato: il vecchio professore di scuola media, ora in pensione.
Forse stava cercando, senza fortuna, per le vie del quartiere, la gloria e l’ossequio un tempo riservatigli dai genitori degli alunni che torturava con i Tre e premiava con i Sette; uomo di Lettere e passi di Omero ripetuti ai muri dell’aula con una passione negli anni scemata dalla frustrazione dell’incomprensione diventata rabbia da sfogare con una riga rossa calcata su un quaderno o con la scritta “respinto” affissa all’albo di giugno appeso fuori dalla scuola.
Non riuscii a cogliere gli indizi di un quarto ignaro cliente della mia fantasia: improvvisamente, come se non l’avessi notata prima, guardai quasi abbagliato la città illuminata a festa e nella così evidente imminenza di un altro ennesimo Natale trovai l’ultima cavia della mia fantasia, quella più facile da indagare.
Allora pensai a un bambino, spensierato e gioioso, incantato dalle luci della mia città, che trascorreva le ore a spiare i negozi di giocattoli vestiti a festa, che con poche monete comprava oggettini inutili da regalare alla mamma, al papà, alla zia, dando ad ogni regalo priorità diverse a seconda del destinatario, priorità quantificabili in piccoli risparmi di mance accumulate durante l’anno.
Pensai a un grande tavolo, ora vuoto e triste, dove la famiglia tutta riunita si sedeva per consumare un banchetto grandioso, quello di “una volta all’anno”, quello di Natale con i tramezzini, la frutta secca, gli agnolotti, l’arrosto, la bagna cauda, il panettone e lo spumante.
E poi la musica, il presepe con le luci intermittenti, il calore di un camino, l’affetto della famiglia, le parole sospese nell’aria delle letterine affettuose, lo scambio dei regali e di baci che sembravano così autentici, così veri.
Tutto è finito ed è finito prima che un virus ci allontanasse dagli altri e da noi stessi: è finito nella dispersione di uomini e donne che fingono di crescere per abbandonare la propria Betlemme, per diventare ricchi, per svuotarsi definitivamente e non provare più nulla, se non un attimo fugace di malinconia che trasforma il giorno più bello dell’anno in un abete spoglio persino degli aghi, anche se ci avevano detto che sarebbe sempre stato verde, anche se ci avevano detto che doveva nevicare e invece la nebbia ha sommerso tutto e tutti.